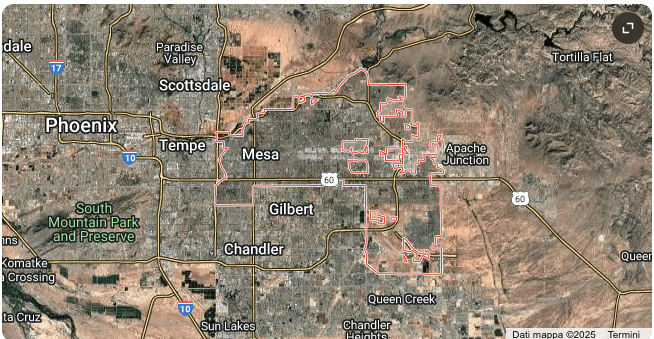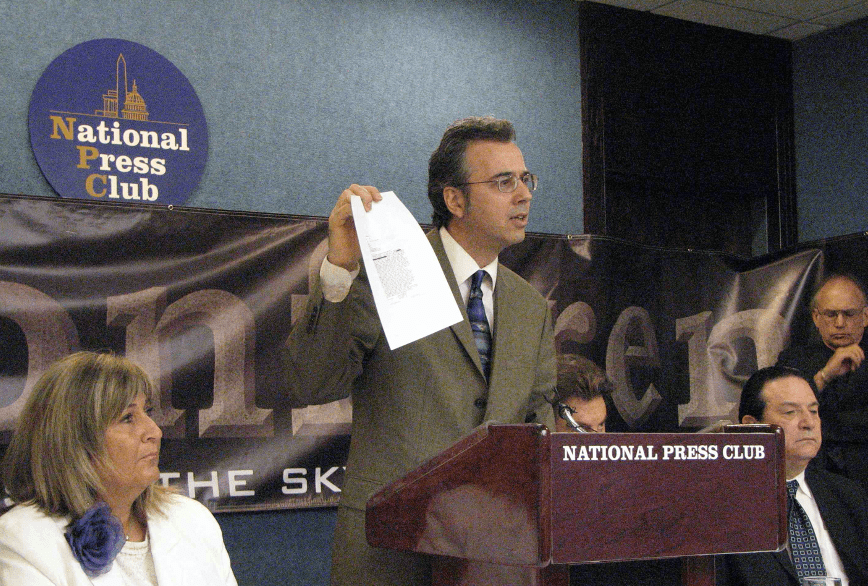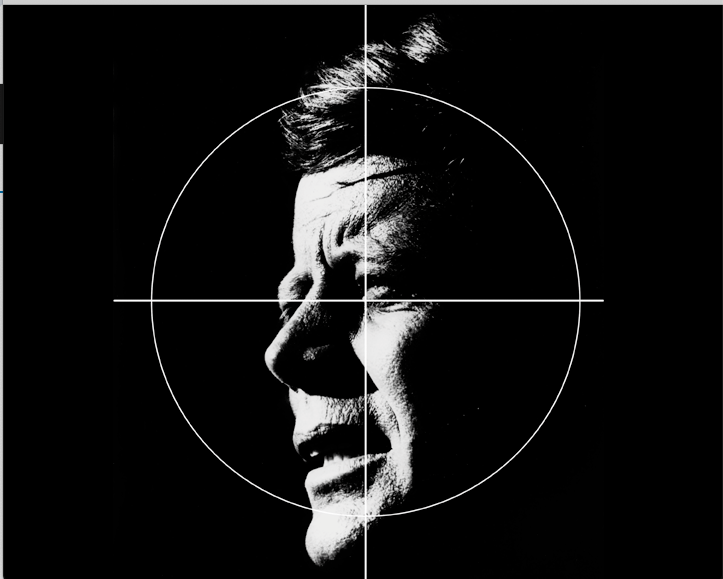Di Maurizio Baiata
11 Febbraio 2026
Uno degli aspetti più sconcertanti del variegato mondo della New Age, riguarda il business che nel nostro Paese vi ruota intorno. New Age… suggestivo, ma chimerico termine che indica in senso lato uno sventolio di stendardi che inneggiano soprattutto alle potenzialità e allo sviluppo globale dell’individuo.
Quell’essere umano che vive nel mezzo della Nuova Era dell’Acquario, ovvero un cambiamento epocale iniziato con gli hippies degli anni Sessanta, ha le facoltà e il dovere di formarsi e migliorarsi attraverso l’approfondimento di pensieri e la pratica di tecniche le cui radici affondano nella Metafisica e nella Spiritualità.
E il cui obiettivo primario e immediato è il sano e consapevole riequilibrarsi con il mondo circostante, l’adoperarsi per il bene proprio e altrui, in armonia con sé stessi, con il pianeta e con l’Universo. In tal senso le distanze che ci separano dal raggiungimento della cosiddetta “Illuminazione” (Samadhi) non sembrano così incolmabili e, soprattutto, ci si accorge che tutto ciò che è portatore di una crescita interiore diviene anche un vettore per il benessere biologico della persona.
Per questo, nella New Age, sono proposti approcci poliedrici e gli operatori “olistici” – per definizione esperti multidisciplinari – si occupano di tutto ciò che non si ferma davanti ai limiti e non si incardina nella ferraglia della ragione occidentale, ma percorre territori che vanno dalle filosofie orientali alle terapie di guarigione psicofisica e di risveglio coscienziale, dal partecipare alla dinamica della trasformazione planetaria al ricollegarsi allo sciamanesimo, dalla meditazione al Reiki, dalle medicine alternative ai viaggi astrali, dalle tecniche del corpo alle arti marziali soft, sino al Channeling, ovvero lo stabilire contatti con entità canalizzate non esistenti nel nostro piano di realtà conosciuto.

Finito il tempo che fu
L’interesse per queste materie sembra essere in costante espansione, con somma preoccupazione per la Chiesa Cattolica, per le scienze ortodosse e per i poteri politici che le sostengono. Non è questa la sede giusta per analizzare le ragioni della “messa all’indice” e delle campagne inquisitorie contro le terapie alternative (il caso Di Bella le avrebbe rappresentate all’unisono), giacché il punto in discussione qui è un altro e meno inquietante, anche se in fondo strabiliante.
Le cosiddette Scienze di Frontiera, le ricerche sul Paranormale, la Medianità, o l’Ufologia e persino l’Astrologia – che hanno solide connotazioni storico/scientifiche – sono discipline che, per chi vi si addentri, vanno affrontate con la massima serietà. Va però detto che non solo la distanza che le separa dalle credenze pseudo religiose o pericolose derive settarie sia abissale e che il “giro economico” che le interessa resti di dimensioni irrisorie rispetto a quello della New Age, è facile per il Cicap e affini avere mano libera per assimilare il tutto in un calderone di affari a spese di gente illusa. A meno che non abbiano a che fare con maestri del calibro di Gustavo Adolfo Rol (nella foto in basso), come capitò ad un malcapitato Piero Angela.
Negli ultimi anni le grandi conferenze sugli UFO a ingresso gratuito sono diventate un lontano ricordo. Gli organizzatori da tempo si trovano costretti a stabilire ingressi a pagamento, anche se a costi contenuti, per poter invitare relatori stranieri o italiani cui vanno riconosciuti gettoni di presenza. Molti si accontenterebbero di vedersi pagate le spese di viaggio e qualche giorno di permanenza nel nostro bel Paese, ma, mentre nessun ufologo (fino a ieri) è una superstar, per i guru della New Age è diverso. Quelli che si muovono dagli USA o dall’Inghilterra e arrivano in Italia non lo fanno per il bene della giusta causa. Loro sono ruote di ingranaggi di affari ben oliati. Che devono portare la buona novella, il messaggio salvifico, per lo Spirito e per l’Anima e questo lo hanno capito anche e soprattutto i guru New Age nostrani. I quali si sono allineati. Sanno che qui non si tratta solo di promuovere la visione astrale dei propri defunti di fresca data o per capire se esiste un mondo nuovo che ci attende nell’ignoto Altrove. Qui si tratta di affidarsi a personaggi che abbiano una credibilità consolidata e che accettino di legare il proprio nome a una macchina che produce alti profitti. Che sia una tre giorni fra le colline umbre circondate da uliveti e vigneti, che sia in una città d’arte come Firenze, di tradizione come Siena o che si debba pagare un pizzo per accedere a distanza alla Fontana di Trevi, la macchina promozionale e organizzativa del tour rende tutto funzionale mettendosi in moto almeno un semestre prima, con un battage che sfrutta internet, i canali youtube, i siti cospirazionisti ora volteggiati allo spirare dei venti del cambiamento e i blog dedicati al settore New age. Nel contempo, si aprono iscrizioni ai corsi e ai seminari intensivi, si lanciano sottoscrizioni, si crea una appartenenza ad un modello di pensiero, ci si registra alle conferenze e alle visite guidate, previste fra tre, sei, nove, dodici mesi. Si deve ottenere il tutto esaurito anzitempo.

Illuminazione All Inclusive
In Italia, un biglietto di ingresso per assistere a una conferenza ad esempio sulle regressioni ipnotiche alle vite precedenti, può aggirarsi sui 250 euro al giorno, vitto e alloggio esclusi. Raramente vengono offerti, allo stesso prezzo, pacchetti “all inclusive” come accade abitualmente negli USA, dove partecipare a un seminario esperienziale e conoscitivo di un luminare qualsiasi non è a buon mercato, ma con 250 dollari si vive un week end intero di conferenze condotte da vari relatori e sei ospite della struttura alberghiera dove si tiene la manifestazione.
Incredibilmente, data la situazione economica generale e nonostante i prezzi proibitivi, in Italia questi incontri richiamano molta gente che non si fa scrupolo di spendere cifre sui 350 euro per una “tre giorni di full immersion”, senza contare i costi di viaggio, pernottamento, eccetera.
Evidentemente, si tratta di persone che non riescono a sfuggire alla morsa psicologica di una immaginaria fine dei tempi, di nefaste predizioni di guerre nucleari, di tenebre che per tre giorni caleranno sulle nostre vite e che solo abbracciando la luce “divina” potremo evitare, di strani allineamenti del sistema solare che ci ricongiungeranno al centro galattico. Per sapere di che morte dobbiamo morire, o cosa dovremmo fare per affrontare un qualsiasi nuovo Armageddon, si è disposti a pagare caro.
Il Paese, diventato ricettacolo di tour mondiali degni delle Rock star internazionali, offre anche spazio ai relatori italiani che hanno preso possesso di un territorio vergine, di un pubblico assetato di saggezza, di menti oscurate dalla paura, rese schiave da politiche che dicono: ragazzi, armatevi, non dovete neppure sostenere costi di trasporto strumenti, allestimento palco, tecnici e apparecchiature Sound & Video, servizi d’ordine, logistica, uffici stampa, pubblicità e promotion… pensiamo a tutto noi, ma voi portateci la vostra “verità”, la faremo pagare fior di quattrini e nessuno dirà niente… mentre i saltimbanchi ex ufologi gongolano, l’informazione alternativa che nasce dal sacrificio di una vita, quella che chiede che avvenga davvero la DISCLOSURE UFO”, resta nel buio, quando ancora troppi si lamentano perché i risultati della ricerca devono essere dispensati gratuitamente.
Come leggere tale bruciante contraddizione se, ad esempio, mettiamo a confronto quanto renda parlare di New Age, anziché di Ufologia e fenomeni di contatto Extraterrestre? Miriadi di persone sono attratte da temi popolari e “commercialmente” remunerativi quali l’al di là, la vita oltre la morte e il contatto con i defunti, che ci dovrebbero riportare sui libri dei padri della Medianità ben più concreti e appartenenti alla nostra vita quotidiana di quanto non si pensi.

Rosemary al patibolo
All’inizio degli anni Duemila vissi, sul palco del Maurizio Costanzo Show un episodio che mi rimase impresso. Rosemary Altea, medium americana famosa in tutto il mondo, dotata di grande carisma e caratterizzata da quella che si definirebbe una forte “personalità magnetica” fu invitata sul palco del teatro Parioli a parlare del suo campo, la comunicazione con i defunti. Rosemary ha il dono della visione psichica, che le consentirebbe anche di conversare con i trapassati in una sorta di channeling diretto, privo di intermediari, seduta stante. Tali entità disincarnate, provenienti da stati dimensionali diversi dal nostro vivere tangibile, le appaiono sotto forma eterica, ma vengono da lei percepite e viste nel loro aspetto fisico. Quindi, alla Altea bastano pochi attimi di concentrazione per sentire e descrivere la presenza di un familiare o di un caro estinto che, collegato in vita a una determinata persona, le è nuovamente accanto in quel momento davanti ad un pubblico affascinato dalla sua capacità mediatrice con l’Aldilà. Nei minuti precedenti la registrazione della seconda puntata del talk show, dietro le quinte Rosemary mi parve a disagio, tesa. Qualcosa sembrava preoccuparla. Le chiesi se andava tutto bene e lei si limitò a sorridermi, mentre la sua manager americana mi rassicurò. Sarebbe andata come sempre, ma così non fu. Non credo ci sia stato alcun concorso del Cicap, ma lo show al Parioli, a un certo punto, prese una piega inaspettata.
Maurizio Costanzo invitò la sensitiva a passare fra le file della platea e ovviamente molte mani si alzarono per chiedere alla Altea un consulto e un contatto con un proprio caro scomparso. Una ragazza si fece avanti e si avvicinò alla medium, che la scrutò e poi, senza esitazioni, disse di vedere accanto alla giovane la figura di un uomo. Emozionatissima, la ragazza la pregò di stabilire una comunicazione e la Altea fece da tramite, dicendole che quell’entità era suo padre, il quale desiderava confortarla e rassicurarla. Una spettacolare messinscena. La Altea era caduta in un puerile tranello. Il padre della ragazza non era affatto morto!

Tornata sul palco, assieme agli altri ospiti, Rosemary Altea più che contrariata era visibilmente scossa e ammutolita. Non ottenendo risposte da lei, Costanzo si rivolse a me e presi le difese della sensitiva americana, sottolineando che con quell’inganno si era cercato di screditare l’intera categoria degli operatori e degli studiosi del paranormale. Ma il rischio che corrono le grandi star della New Age sembra comunque lautamente ricompensato.
Maurizio Baiata
Per essere aggiornati sulle attività editoriali di M. Baiata si consiglia di seguire il suo canale Youtube: https://www.youtube.com/@mauriziobaiatachannel